Da Caravaggio ai caravaggeschi
Un libro e una mostra a Firenze con novanta teledi Federica Marino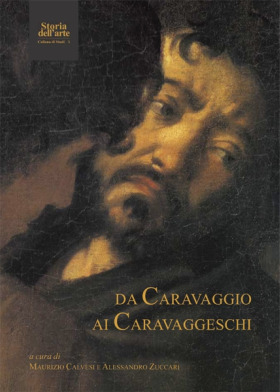 Da Roma a Firenze sotto il segno di Caravaggio e dei caravaggeschi, nell’anno in cui si celebra il quarto centenario della morte di Michelangelo Merisi.
Da Roma a Firenze sotto il segno di Caravaggio e dei caravaggeschi, nell’anno in cui si celebra il quarto centenario della morte di Michelangelo Merisi.
Mentre a Roma si conclude a fine giugno la capofila “Caravaggio”, apre domani fino al 17 ottobre nel capoluogo toscano la mostra “Caravaggio e caravaggeschi a Firenze”, in un percorso diffuso che tocca Palazzo Pitti, gli Uffizi e e Villa Bardini.
Data la portata nazionale delle celebrazioni, il Comitato nazionale ha scelto anche la localizzazione tematica, agganciando l'artista al contesto cittadino, soprattutto per quanto riguarda i continuatori del suo stile. Se non sono infatti documentati soggiorni significativi del Caravaggio alla corte medicea, l'artista vi è però massicciamente presente con opere sue e dei continuatori fin da subito, grazie al senso artistico di Ferdinando I e Cosimo II de' Medici, oltre che dei diversi committenti e collezionisti privati fiorentini.
A Palazzo Pitti e agli Uffizi, otto capolavori di Caravaggio, a documentarne tutta la parabola creativa: la Medusa e il Bacco tra loro, cui si aggiungono due ritratti, per Maffeo Barberini e per un cardinale – tradizionalmente il Baronio, ma la critica solleva dubbi.
Novanta tele di caravaggeschi, approdate a Firenze entro i vent'anni dalla morte del Merisi, mostrano l'attenzione della corte toscana per la novità rappresentata da Caravaggio, poco riconosciuta, invece, dagli artisti locali, che preferirono la tradizione del disegno accademico toscano al vento di naturalismo arrivato da Roma.
Seconda sede espositiva è Villa Bardini, dove sono esposti i dipinti della Fondazione Roberto Longhi: lungo il tema della modernità, la vita artistica del Caravaggio e dei suoi primi seguaci nella collezione dello storico d'arte morto nel 1970.
Diversi gli spunti offerti dall'esposizione fiorentina, che arriva quarant'anni dopo l'ultima grande mostra dedicata al Caravaggio nella città toscana: in quarant'anni, segnalano i curatori di oggi, sono aumentate le opere presenti e mutate alcune attribuzioni, nel progresso di una ricerca in continuo – e fecondo – divenire.
Tra i contenuti della mostra, spicca, nel saggio critico del curatore Gianni Papi, il ruolo dei Gentileschi, padre e figlia. Orazio, toscano e figlio di pittore fiorentino, opera a Roma e si fa caravaggesco. Artemisia nasce a Roma e si trasferisce per 7 anni a Firenze, tanto che Papi la definisce una “immissione caravaggesca, fisica e concreta” a Firenze.
I due Gentileschi, sostiene Papi, sono i caravaggeschi più compiutamente fiorentini, certamente grazie alla frequentazioni romane con il Merisi. Gli artisti locali sembrano più refrattari al fascino del naturalismo; Papi ne individua tuttavia lampi e tentazioni in una dozzina di tele di artisti diversi e nei disegni dal naturale di Andrea Commodi, un episodio isolato e forse frutto di una ricerca personale e indipendente dell'artista. Se non si può parlare di “caravaggismo fiorentino”, conclude il saggio, la linea naturalistica è presente alla corte dei Medici e avrebbe potuto validamente contrapporsi ai “languori melodrammatici e alle ambiguità sentimentali” - scrive Papi - che ebbero la meglio a Firenze. Si avverte la tentazione del “what if”, ma il critico sa resistere e registra: “non è stato così”.
In un secondo saggio, Papi si interroga sulla forza rivoluzionaria di un’opera romana, il Martirio di San Matteo in San Luigi dei Francesi, e la mette in relazione con un’opera di Cecco del Caravaggio. La tela romana inaugura il naturalismo moderno rompendo con la tradizione e con le opere precedenti del Merisi: pennellate ampie e figure grandi, una certa infedeltà al soggetto, la scelta di mettere letteralmente in luce i tre carnefici, quasi nudi in primo piano, preferndoli all’anziano martire. Tratti analoghi nella pala d’altare chiesta a Cecco per la fiorentina Cappella Guicciardini, mai però arrivata nella chiesa di Santa Felicita, perché rifiutata dallo stesso committente. Anche in quest’opera, che Papi riconosce nella Resurrezione oggi a Chicago, figure misteriose hanno il primo piano e la luce su di sé, e il naturalismo viene portato all’estremo, tanto che non di Resurrezione si tratta- sostiene Papi- ma di uno studio per un dipinto sul tema, ambientato nell’atelier del pittore, in una sorta di iperrealismo che – probabilmente - decretò il rifuto dell’opera. Cosa sarebbe accaduto se la Pala di Cecco fosse arrivata a destinazione? Papi chiede e risponde: non è successo allora e nemmeno oggi, vane infatti tutte le richieste di un prestito da Chicago per la mostra fiorentina.
Prima che a Firenze, di Caravaggio e caravaggeschi si occupa il volume, dal titolo quasi identico, presentato oggi a Roma. Dalla raccolta di diciotto saggi, curata dal Comitato nazionale per il Caravaggio, esce un ritratto a tutto tondo dell’artista, fuori dallo stereotipo “genio e sregolatezza”, per ricostruirne il percorso creativo e biografico.
Gli esordi lombardi e il contesto in cui il giovane Merisi comincia a farsi conoscere, di parrocchia in parrocchia, nel saggio di Giacomo Berra, l’artista attento al sociale e vicino alla Controriforma nelle pagine di Maurizio Calvesi, lo studio iconologico delle opere giovanili con Dalma Frascarelli, tra tutte le “Canestre” ricolme di frutti lette in chiave simbolica come richiamo eucaristico.
Laura Testa riscopre in archivio le relazioni tra il Cavalier d’Arpino e un Caravaggio appena arrivato a Roma e ne ricostruisce le prime frequentazioni capitoline, mentre gli studiosi Massimo Moretti, Marco Pupillo e Vincenzo Abate raccontano ruolo e figura di tre importanti committenti romani di Caravaggio, la coppia Ermete e Orinzia Cavalletti e il monsignor de Torres.
Onore al “nemico” Giovanni Baglione nel saggio di Claudio Strinati, mentre si torna all’analisi iconografica nelle pagine che Maurizio Marini dedica a un “nuovo” San Giovannino e alla sua copia, seguendone i passaggi di mano.
Quattro caravaggeschi sono al centro di altrettanti saggi: ad Angelo Caroselli, “pasticciere di quadri”, Alessandro Zuccari “restituisce” la paternità del Giudizio di Salomone; di Orazio Gentileschi e della sua “camera oscura” ante litteram, impiegata per effetti ottici e pittorici innovativi, si occupa Massimo Pulini, mentre Gianni Papi si dedica a Valentin de Boulogne e altri “minori”. La scoperta di una nuova tela di Nicolas Tournier, infine, viene illustrata dal suo specialista Axel Hemery.
L’ultima sezione è centrata sulle questioni di catalogo e attribuzioni: indagini e analisi spettrografiche per una storiografia delle copie dal Longhi ai giorni nostri nelle pagine di Barbara Savina, per Stefania Macioce focus sul ruolo fondamentale delle stampe per la conoscenza dell’artista. “Da Caravaggio ai caravaggeschi” si conclude sui saggi di Herwarth Roettgen e Frances Gage: nuove ipotesi interpretative sui dipinti della Cappella Contarelli nella chiesa romana di San Luigi dei Francesi per il primo, per il secondo una lettura rinnovata della Teoria della bellezza secondo Giulio Mancini, che di Caravaggio fu contemporaneo biografo e critico.
Un testo di spessore e non un libro “occasionale”, legato cioè all’occasione propizia delle celebrazioni caravaggesche; certo un’occasione per approfondire questioni e aprire nuovi filoni di ricerca in un terreno che sembra riservare ancora molte sorprese.