Se la memoria diventa storia
Benedetta Tobagi racconta suo padre. A Torino anche la 'lectio magistralis' del cardinal Angelo Bagnasco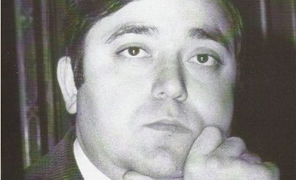
di Raffaella Miliacca
Dalla memoria alla storia, un passaggio che sembrerebbe facile e naturale ma che spesso così non è, come spiega Benedetta Tobagi parlando del suo libro “Come mi batte forte il tuo cuore. Storia di mio padre” (ed. Einaudi). Walter Tobagi, giornalista del Corriere della Sera, fu ucciso dalla Brigate Rosse nel maggio del 1980. Lei era piccolissima. Partivo da una condizione di assenza della memoria personale, racconta la scrittrice, e ho capito che dovevo fare un percorso più vicino a quello degli storici. Volevo ricostruire la figura di mio padre con una dimensione personale che riuscisse a parlare con una dimensione storica. Con un archivio privato come era il suo studio mi sono chiesta: che fare? L’accesso alle fonti per me è nato da un moto affettivo.
Nel libro ho cercato d’integrare la memoria con una ricostruzione oggettiva, d’intrecciare pubblico e privato, di far dialogare diverse memorie proprio per rendere onore a mio padre. Lui, cattolico, socialista, persona molto pacata, era capace di mettere in contatto tra loro punti di vista molto lontani, in un periodo di conflitti politici molto accesi e di forte violenza verbale. Benedetta Tobagi ripercorre l’escalation del terrorismo di quegli anni, dalla nascita delle Brigate Rosse, nel ’70, ai primi omicidi, al picco di vittime nel 1980, e al moltiplicarsi di bande armate, di un terrorismo diffuso, per il quale è stata molto importante la componente mediatica. E poi il libro è stato anche l’occasione per uno studio sull’uso politico della memoria, dice. Si sono susseguiti anniversari con celebrazioni diverse: quelle per il Tobagi cattolico, quelle per il Tobagi socialista, quelle per il Tobagi giornalista. Ma in tutte queste dove sta mio padre? Anche per questo ho sentito l’esigenza di scrivere su di lui.
Memoria, storia, romanzo
Qual è il rapporto tra memoria e storiografia e, ancora, tra questa e il romanzo? Ne parlano lo storico Alessandro Barbero e la scrittrice Melania Mazzucco. Faccio lo storico di mestiere e lo scrittore a tempo perso, dice Barbero. Per scrivere un romanzo storico, il lavoro di ricerca non è diverso da quello degli studiosi: lavorare in archivio, sulle fonti. Ma è diverso lo scopo e nel romanzo ti puoi prendere più libertà. In Italia, il tema della memoria è bruciante, usato e manipolato, secondo Barbero. Si parla troppo di memoria e molto poco di storia. La memoria non può essere condivisa, è soggettiva, spiega, è la storia che dovrebbe essere condivisa. Anche se non è una scienza esatta, ha dei criteri, una verificabilità, un approccio critico che prescinde dal ricordo di ciascuno. Ho imparato a lavorare sulle fonti fin dal romanzo “Vita”, un libro sull’immigrazione vissuta nella mia famiglia, dice Melania Mazzucco. La memoria mi ha portato alla storia. In famiglia, le persone anziane raccontavano la loro vita. Fin da ragazzina ho imparato ad ascoltare mantenendo il piacere diffidente del lettore di romanzo. Diffidenza che mi ha permesso di conciliare il ricordo soggettivo con la ricostruzione degli storici. Per me, aggiunge, storia e memoria non possono essere due termini separati.. Il suo ultimo romanzo racconta la vita di Maria Tintoretto, della sua famiglia nella Venezia del 1500. Le fonti antiche, spiega la scrittrice, risentivano del racconto del padre Tintoretto: inventa la vita di Marietta, decidendo cosa far sopravvivere di lei. Io mi sono sentita sfidata nel ricostruire la sua vera identità. Volevo scrivere un racconto sulla base documentaria di tracce lasciate o nascoste negli archivi.
Chiesa ed emergenza educativa
Di fronte alla cosiddetta svolta antropologica, che propone una nuova visione dell’uomo, la Chiesa affronta la sfida. Da qui parte la “lectio magistralis” del cardinal Angelo Bagnasco, presidente della Cei, in occasione della pubblicazione del libro “Emergenza educativa” (Edup). Spesso non si valorizzano i patrimoni culturali, diventano muti testimoni del passato, dice il cardinale, ma senza tradizione non si trae linfa dalle radici. Questa amnesia culturale del nostro tempo misconosce le radici cristiane, la società non è più fondata su valori condivisi e universali. La coltivazione della memoria non rinchiude la Chiesa nel passato. L’interesse per le problematiche politiche e civili trova impulso nella sua missione apostolica, non si tratta d’ingerenza, spiega Bagnasco. E insiste sul dialogo tra fede e ragione: se la ragione è debole, la fede non è forte. Senza recupero di fiducia nella ragione, non c’è possibilità di educazione, di umanesimo. Compito delle istituzioni cattoliche e pedagogiche è instillare il gusto nella ricerca del vero e del bene, conclude, educare alla razionalità, mantenere nei giovani il gusto della verità che spesso soccombe alla categoria dell’utile.