Nel blues dipinto di blues
Nuovo album per Eric Clapton e cd postumo per Ernesto De Pascaledi Maurizio Iorio
(maurizio.iorio@rai.it)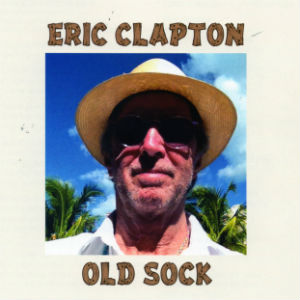 Eric Clapton – Old sock (Bushbranch)
Eric Clapton – Old sock (Bushbranch)
Il buon vecchio Eric Clapton è per tutti, da sempre, “Slowhand” (Manolenta), il nomignolo più ossimoro che ci sia. Adesso, a 68 anni appena compiuti, intitola il suo nuovo album, il ventesimo della sua ultraquarantennale carriera, “Old sock”, mezza calzetta. Quasi a sminuire il suo status di icona del blues-rock. Che, ovviamente, non subisce nessuna “diminutio” dal passar del tempo. Anzi, proprio il fatto di non dover dimostrare nulla a nessuno, lo rende assolutamente libero di vagare per territori musicali senza costrizione alcuna. A scanso di equivoci, Clapton ha anche fondato un’etichetta personale, la Bushbranch. “Old sock” (si dice che il titolo gli sia stato suggerito dall’amico David Bowie), è un album leggero, quasi un “take it easy”, che mette insieme bei classici, anche remoti, per lo più caduti nel dimenticatoio. Come “The folks who live on the hill”, anno 1937, di Oscar Hammerstein e Jerome Kern, “Born to lose”, di Ted Daffan (1943), “Goodnight Irene, di Ledbetter e Lomax (1933). O, ancora, “Our love is here to stay”, scritta nel 1938 da George e Ira Gershwin per il film “The goldwin follies”. Insomma, roba da vinile impolverato, che Clapton ripropone in chiave leggera e al tempo stesso sofisticata, aiutato, in “All of me”, classico del jazz del 1931, dal suo amico Paul McCartney, altro amante della musica dei bei tempi. Ma “Old sock” non è solo una raccolta di vecchi standard, perché in parecchi brani fa capolino il reggae; già, il reggae, altra vecchia passione del nostro (ricordate “I shot the sherif” e “Knockin’ on heaven’s door?”). Per esempio in “Till your well runs dry”, dello scomparso Peter Tosh, la stella numero due della musica giamaicana. Il tono si alleggerisce assai con l’inserimento di due brani di Nikka Costa (pensa tu!), “Gotta get over” ed “Every little thing”, con la riesumazone di vecchi blues di Taj Mahal (“Further on down the road”) e di Gary Moore (“Still got the blues”, con Stevie Winwood all’Hammond), con un dimenticato classico del soul di Otis Reding, come “Your one and only man”. Fra i tanti ospiti, il vecchio J.J. Cale (è l’autore di “Cocaine” e “Afther Midnight”), Chaka Khan, Taj Mahal, e i già citati Paul McCartney e Stevie Winwood. A tirar le somme, Clapton, che si è anche auto- fotografato per la copertina in tenuta vacanziera, non ha scritto una nota. Ha riscritto, come al solito con grande classe. Infatti questo album va ascoltato come un classico. 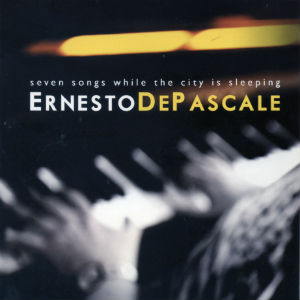 Ernesto De Pascale – Seven songs while the city is sleeping (Il popolo del blues)
Ernesto De Pascale – Seven songs while the city is sleeping (Il popolo del blues)
Ernesto De Pascale, caro amico e collega di scorribande radiofoniche notturne (Rai Stereonotte) , se n’è andato due anni fa, in silenzio, come quello della città che dorme mentre le sue canzoni ne percorrono l’etere. Ernesto era giornalista, scrittore, conduttore radiofonico, produttore musicale e musicista. Questo mini-cd è il terzo da solista della sua breve carriera (gli altri: “Morning manic music”, 2007, e “My land is your land”, 2008), ed è stato completato dallo staff de “Il popolo del blues”, etichetta musicale e sito web che lui aveva fondato nel 1996 , prendendo a prestito il titolo di un famoso libro di Leroi Jones. De Pascale non è riuscito a completare il lavoro per questo album, che è rimasto un grezzo finché Giulia Nuti e Guido Melis, membri della band degli Underfloor, non ci hanno rimesso le mani e ne hanno completato gli arrangiamenti, appena abbozzati. Il titolo è quanto mai illuminante: “Seven songs” è scritto apposta per il popolo della notte, lo stesso che ha cantato Jovanotti: “la gente della notte
fa lavori strani/
certi nascono oggi
e finiscono domani/
baristi spacciatori
puttane e giornalai/
poliziotti travestiti
gente in cerca di guai/
padroni di locali
spogliarelliste
camionisti metronotte/
ladri e giornalisti
fornai e pasticceri/
fotomodelle
di notte le ragazze
sembrano tutte belle”. Era questa l’umanità varia che ascoltava Stereonotte, il pubblico per il quale De Pascale costruiva le proprie scalette. Le sette canzoni, tutte scritte dall’autore, che canta e si accompagna al piano, sono una sorta di soffice tappeto sul quale far volare i propri sogni. Morbide, svasate, prive di spigoli, con una punta di malinconia (sennò che blues è?). Infatti non è blues. O almeno non del tutto. Direi che siamo più dalle parti del cantautorato americano d’autore, alla Randy Newman, o alla Billy Joel, perfino alla Bruce Hornsby, con belle punte di negritudine. Bandita la sezione ritmica, si affacciano qua e là dei fiati, e degli archi (troppi), che tendono a far prendere una piega da musica da film. Su tutte “We were one”, arricchita dalla tromba di Fabio Morgera e dai cori femminili delle “Voci in transito”. Un piccolo album, scritto da un musicista “da diporto”, che conosceva la musica meglio di molti professionisti, e che aveva trasformato una passione in un mestiere a 360°. Scritto con delicatezza e una velatura di malinconia, da ascoltare quando la città, fuori, dorme.