Le insidie di una professione
'Le regole dei giornalisti - Istruzioni per un mestiere pericoloso'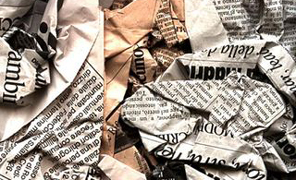
di Rita Piccolini
La condanna inflitta all’allora direttore di “Libero” Sallusti (ora a capo del “Giornale”), a 14 mesi di reclusione senza condizionale per il reato di diffamazione, riapre il dibattito su alcune insidie proprie della professione giornalistica e sugli eccessi di alcune punizione previste. E’ nelle librerie un saggio: “Le regole dei giornalisti. Istruzioni per un mestiere pericoloso”, di Caterina Malavenda, Carlo Melzi d’Eril e Giulio Enea Vigevani, in cui vengono messi in evidenza aspetti della nostra legislazione in materia di libertà di stampa a dir poco ambigui. Il saggio è di grande interesse non solo per gli addetti ai lavori, ma per tutti i lettori che, per godere di un’informazione libera, hanno bisogno di giornalisti liberi. Il libro è edito dal Mulino.
“No al carcere per i giornalisti condannati per diffamazione a mezzo stampa”. E’ stata questa la reazione dei giornalisti italiani alla condanna di Sallusti espressa per tutti da Franco Siddi, segretario della Fnsi (Federazione Nazionale Stampa Italiana) che il 9 ottobre scorso, in audizione in Commissione Giustizia del Senato sulla riforma inerente al reato di diffamazione, ha chiesto mezzi di contrasto efficaci a questo grave reato, “dal giurì, all’obbligo di rettifica entro sette giorni”, alle sanzioni di tipo economico già previste dalla legge, ma “no agli strumenti intimidatori” e estremi come il carcere.
Anche dall’Anm (Associazione Nazionale Magistrati) lo stesso auspicio. No al carcere per i giornalisti condannati ma sanzioni per “questo gravissimo reato” che siano “efficaci”. “Sanzioni pecuniarie modeste non sono dissuasive- rileva il presidente dell’Anm Rodolfo Sabelli- la rettifica tardiva o in forma non equivalente all’articolo non è una soluzione efficace. Piuttosto si potrebbe pensare a sanzioni pecuniarie elevate, e anche a misure interdittive, soprattutto se si è di fronte alla reiterazione o a campagne di stampa contro qualcuno”, ma la prigione no, è una punizione eccessiva e inaccettabile.
Ma da dove nascono alcune delle ambiguità della legge? Leggiamo dalle pagine del libro: “Un giornalista, pubblicando un solo articolo o mandando in onda un solo servizio, può essere incriminato per diffamazione, trattamento illecito dei dati personali, violazione del segreto d’ufficio, pubblicazione arbitraria di atti d’indagine e, se gli va male, per ricettazione, trascinando con sé, per omesso controllo, il suo direttore ed economicamente il suo editore”. C’è da che preoccuparsi! Certo il giornalista deve evitare assolutamente di diffamare, ma a volte l’accusa di diffamazione è legata alle sensibilità individuali e chiunque, a torto o ragione, può sentirsi “diffamato” e querelare, intanto la presunta vittima non rischia nulla, anche nel caso in cui il giudice, dopo anni di attesa, le dia torto. Questo non vale soltanto per la diffamazione, ma anche per “la tutela della privacy”:gli strumenti offerti a chi decida di tutelare la propria reputazione sono praticamente a costo zero, se si escludono gli onorari dell’avvocato pagati, in caso di vittoria, da chi soccombe.
A questo punto al giornalista può accadere di trovarsi imbrigliato da lacci e lacciuoli, tali da mettere in pericolo la sua serenità professionale, perché potrebbe sbagliare anche non volendo, perché “non sono, infatti, le regole, pure numerose e complesse, a limitare di fatto la libertà del giornalista, ma la loro indeterminatezza e la difficoltà di ricavarne sicure linee di comportamento, oltre che l’abuso del ricorso ai giudici”. La legge , che rimanda al codice deontologico adottato dal Garante, con delibera del 29 luglio 1998, fra i limiti introdotti prevede quello dell’”essenzialità dell’informazione”, che è un concetto un po’ vago. Chi stabilisce quali siano veramente gli elementi importanti per comprendere appieno una notizia ad esempio di cronaca? Le mitiche cinque regole del giornalismo anglosassone: Chi? Dove? Quando? Come? Perché? Hanno ancora ragione di essere adottate? L’indeterminatezza è doverosa quando si parla di minori, ma sempre più spesso il cronista sceglie autonomamente di omettere particolari significativi, come il luogo in cui è avvenuto un fatto per non renderne riconoscibili i protagonisti. Può capitare che alcuni particolari non siano infatti graditi alla vittima, o ai testimoni, o ai familiari degli uni e degli altri, e si potrebbe essere vittime di sanzioni. Tutto questa prudenza a volte va a scapito della completezza dell’informazione, solo in nome della quale ci si propone di diffondere particolari significativi, non con l’intento di offendere chicchessia. Per non “sbagliare” quindi si omettono i nomi, a volte il luogo, persino la dinamica di un fatto criminoso. La notizia è essenziale ma vaga. Per questi motivi sono i cronisti giudiziari quelli più esposti alle insidie di norme irragionevoli, ma nessun giornalista è comunque esente da rischi anche molto seri. Questi sono solo alcuni esempi presi dalle pagine del saggio sufficienti a chiedere che venga fatta chiarezza su una materia fondamentale per una informazione libera in una società libera e democratica.
La nostra Costituzione ovviamente tutela la libertà di informazione, ma tutela anche altri diritti, come quello alla privacy e alla protezione della diffamazione, diritti che a volte possono essere in contrasto tra loro. I tre autori del libro, due avvocati e un professore di Diritto costituzionale, ci aiutano a orientarci in una materia complicata, irta di ostacoli e insidie per tutti gli operatori dell’informazione.
Gli autori:
Caterina Malavenda è avvocato esperto di diritto dell’informazione. Tiene corsi d’insegnamento presso i centri di formazione e per il giornalismo di Perugia e Urbino, e in vari master a Milano.
Carlo Melzi d’Eril. Avvocato esperto di diritto dell’informazione e di internet. Insegna nell’Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino e tiene lezioni in vari corsi universitari e master a Milano.
Giulio Enea Vigevani. Professore di Diritto costituzionale e Diritto dell’informazione e della comunicazione nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano- Bicocca.
“L’affaire Sallusti”
Il saggio sulle regole della professione è uscito in concomitanza con la vicenda giudiziaria del direttore del “Giornale“. Ne riassumiamo le tappe.
Sallusti è accusato di diffamazione per un articolo apparso nel febbraio 2007 su Libero, giornale che all'epoca dirigeva, a firma Dreyfus. Nell'articolo si commentava la vicenda dell'aborto di una ragazzina di 13 anni, che non volendo rivolgersi al padre per chiedere la necessaria autorizzazione, d'accordo con la madre aveva chiesto al giudice tutelare il permesso di interrompere la gravidanza. L'autore celato dietro lo pseudonimo, attaccava il magistrato e i genitori, parlando di «aborto coattivo». E aggiungeva una serie di falsità, sostenendo che la ragazza era contraria all'aborto, quando invece aveva regolarmente firmato la richiesta assieme alla madre. Sallusti, responsabile dell'articolo e dei titoli a corredo in quanto direttore del giornale, in primo grado aveva ricevuto una condanna a cinquemila euro di risarcimento. In Appello i giudici avevano modificato la pena in un anno e due mesi di detenzione. Ma senza sospensione condizionale per il pericolo di reiterazione del reato. Dal 26 settembre scorso la condanna è definitiva. L’approvazione del disegno di legge per la riforma del reato di diffamazione a mezzo stampa, che prevede l’abolizione del carcere, potrebbe “salvare” il direttore del “Giornale”.
Ma è proprio di questi giorni la notizia che è slittata la riforma del reato di diffamazione. La commissione Giustizia del Senato non si esprimerà più in sede deliberante sul ddl che dovrà passare all’esame dell’Aula. I tempi si allungano e la sorte di Sallusti è dunque in bilico: a giorni potrebbe diventare esecutivo l’arresto del direttore del “Giornale”.