Nuovi giardinieri per giardini antichi
Intervista a Luigi Zangheri
di Laura Mandolesi Ferrini
(l.mandolesi@rai.it)
Fondi europei per il restauro del verde. E’ quanto riguarda un’iniziativa partita a maggio e che andrà avanti per tutto giugno in Toscana. Unione Europea, Italia e Regione Toscana si sono infatti accordate per istituire un corso, gratuito e aperto ai disoccupati che intendano “approfondire le proprie conoscenze e competenze nell'ambito del restauro/manutenzione di giardini di interesse storico”. Se ne fa promotore l’Ente senese Scuola edile, che formerà giardinieri specializzati nel lavoro all’interno dei giardini storici. Un esempio da seguire, se pensiamo allo stato di abbandono in cui versa buona parte del patrimonio monumentale italiano, giardini storici compresi. Come a Pompei, dove l’unico giardiniere che cura la vegetazione nel sito archeologico unico al mondo, andrà in pensione fra un anno senza essere sostituito. Eppure grazie alla specificità di Pompei furono fatte scoperte importanti proprio nel campo della paleobotanica, studiando le analisi su semi e pollini rinvenuti negli scavi. Scoperte che portarono, dagli anni ’70 a una nuova attenzione verso i reperti botanici, allo studio dell’archeologia e dei giardini antichi. Picchi d'eccellenza che non sono mai mancati nel nostro Paese, ai quali però non ha fatto sempre riscontro un piano di conservazione e manutenzione quotidiana del patrimonio culturale. Abbiamo chiesto un parere a proposito, a Luigi Zangheri, architetto, docente di restauro del verde storico all'Università di Firenze e curatore del restauro di numerosi giardini antichi. Professor Zangheri, come accoglie questo corso di "formazione per la progettazione e il restauro di aree verdi e giardini storici"? Quanto è importante formare figure professionali di questo tipo? E quanto è utile che figure di questo tipo affianchino quelle dello storico, del restauratore o del paesaggista?
Zangheri: “Solo da pochi anni, in Italia si è provveduto alla formazione di figure professionali nel campo del restauro dei giardini capaci di impiegare tecnologie adeguate alla storicità dei luoghi, e che operano con attenzioni differenti da quelle proprie a chi si occupa della manutenzione del verde moderno. Benemerita è stata la Scuola Edile che, prima a Firenze e ora a Siena, si è preoccupata con successo della formazione di giardinieri specializzati nella cura del verde storico. Nel caso di Siena, forse si deve considerare ridondante la titolazione di un corso dedicato alla “progettazione e restauro di aree verdi e giardini storici”, destinato ai disoccupati e di sole 200 ore. Cosa ne direbbe un vero giardiniere come Pietro Porcinai che ha votato tutta la sua vita alla progettazione delle aree verdi e al restauro dei giardini storici?”
Ma Pietro Porcinai, come Lei ricorda in “Storia del Giardino e del Paesaggio” (Olschki, 2003), "si batté a lungo per l’insegnamento del verde”. Possiamo immaginare che in questo caso Porcinai si augurerebbe che se il corso raggiungesse il suo scopo, darebbe agli studenti sufficienti motivazioni per continuare a “studiare”?
”Porcinai aveva ideato presso il suo studio a Fiesole dei corsi di architettura del paesaggio e non di giardinaggio. Una sorta di master a cui avrebbero potuto iscriversi curiosi o dilettanti, ma soprattutto i giovani professionisti che desideravano approfittare della grande esperienza di un maestro. L'insegnamento del verde sarebbe stato per lui una sorta di autobiografia, e un racconto delle sue esperienze positive e negative. Nei suoi ultimi anni anche lui studiava ancora costantemente come testimoniano le riviste acquistate in ogni paese, e da lui chiosate negli articoli più interessanti. Una sorta di aggiornamento che si imponeva e che lo interessava a tutto non certo passivamente. In questo senso il corso di formazione senese sarà positivo se avrà trasmesso "sufficienti motivazioni per continuare a studiare".  Lei racconta che al primo colloquio sui giardini storici dell’Icomos, nel 1971, René Pechère sostenne che “fra vent’anni il nostro lavoro sarà forse uno dei primi mestieri del mondo (…) è urgente preparare degli specialisti di alto lilvello” (“Storia del giardino e del paesaggio”). Ora che sono passati più di quarant’anni molto è cambiato. Si sono moltiplicati corsi di formazione, le specializzazioni e le competenze. Quante lacune restano da colmare e quali sono oggi le priorità?
Lei racconta che al primo colloquio sui giardini storici dell’Icomos, nel 1971, René Pechère sostenne che “fra vent’anni il nostro lavoro sarà forse uno dei primi mestieri del mondo (…) è urgente preparare degli specialisti di alto lilvello” (“Storia del giardino e del paesaggio”). Ora che sono passati più di quarant’anni molto è cambiato. Si sono moltiplicati corsi di formazione, le specializzazioni e le competenze. Quante lacune restano da colmare e quali sono oggi le priorità?
“A René Pèchere e al Comitato Icomos-Ifla è universalmente riconosciuto il merito di avere formulato, nel 1981, il testo della Carta di Firenze per il restauro dei giardini storici. Nel primo articolo di questo documento si afferma che il giardino storico presenta un interesse pubblico e che, come tale, è da considerare un ‘monumento’. Ugualmente all’articolo 20 si rileva come il giardino storico richieda cure continue da parte di personale qualificato. E’ incredibile pensare che l’Italia di quegli anni fosse del tutto priva di operatori, dagli architetti del paesaggio ai giardinieri, formati dalla scuola o dall’università. Oggi, fortunatamente per i paesaggisti abbiamo corsi di laurea, master e dottorati, ma purtroppo non abbiamo ancora riconosciuto seriamente la loro professionalità. Ad esempio: del restauro dei giardini storici non ne attendono soltanto gli architetti del paesaggio che hanno avuto una preparazione specifica, ma se ne possono occupare liberamente anche tanti altri professionisti con altra formazione, e questo è un bel problema contrario al rispetto delle competenze specifiche. In Europa è attiva dal 1991 la Eureopean Conference of Landscape Architecture Schools, che cerca di promuovere corsi di studio con diplomi che siano validi e riconosciuti in ogni paese del vecchio continente, ma trova molte difficoltà”.
Professor Zangheri, quando è di fronte a un nuovo progetto di restauro, con quanto rigore si attiene a un recupero filologico e quanto invece può rivisitare attraverso il filtro delle esperienze e delle tecniche dell’epoca in cui viviamo? Quanto insomma si deve conservare e fino a che punto si può osare?
"Questa è una domanda da un milione di dollari! Tutto dipende dalla cultura, dalla preparazione e dall’esperienza dell’operatore a cui è affidato l’incarico del restauro di un giardino storico, anche se va precisato che con la parola ‘restauro’ si deve intendere solo ‘conservazione’. All’articolo 15 della Carta di Firenze si prescrive che “Ogni restauro e a maggior ragione ogni ripristino di un giardino storico dovrà essere intrapreso solo dopo uno studio approfondito che vada dallo scavo alla raccolta di tutta la documentazione relativa al giardino e ai giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere scientifico dell’intervento. Preliminare all’intervento stesso, questo studio dovrà portare alla elaborazione di un progetto che sarà sottoposto a un esame e a una valutazione collegiale”. Nella pratica quotidiana, spesso tutto questo non accade”. 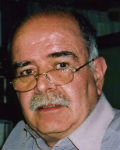 Biografia: Luigi Zangheri è docente di Storia del giardino e del paesaggio e di Restauro del verde storico nella Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze. Presidente del Comitato Scientifico Internazionale ICOMOS-IFLA per i Paesaggi Culturali dal 2004 al 2008, presiede ora l’Accademia delle Arti del Disegno. Come architetto si è occupato del restauro di edifici pubblici monumentali, di giardini e di parchi storici. E’ autore di oltre 200 pubblicazioni sulla storia e sul restauro dell'architettura, del giardino e del paesaggio.
Biografia: Luigi Zangheri è docente di Storia del giardino e del paesaggio e di Restauro del verde storico nella Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze. Presidente del Comitato Scientifico Internazionale ICOMOS-IFLA per i Paesaggi Culturali dal 2004 al 2008, presiede ora l’Accademia delle Arti del Disegno. Come architetto si è occupato del restauro di edifici pubblici monumentali, di giardini e di parchi storici. E’ autore di oltre 200 pubblicazioni sulla storia e sul restauro dell'architettura, del giardino e del paesaggio.
Nelle foto: Il Colosso dell'Appennino del Giambologna a Villa Demidoff, presso Pratolino e il Chiostro di Santa Chiara a Napoli. Sono due delle opere restaurate grazie al contributo dell'architetto Zangheri. Nell'immagine in bianco e nero la ricostruzione di un'aiuola nel Pleasureground di Glinicke. Da "Storia del giardino e del paesaggio" (Olschki, 2003).